Una rosellina, quando sono nata. Così dicevano dinanzi a un viso dolce e pieno di futuro. Il mio corpo di bambina è stato sempre fatto di occhi grandi e profonda magrezza. Le dita lunghe e sottili da pianista, le gambe esili da ginnasta, i capelli lunghissimi poi cortissimi e così ad anni alterni.
Le gambe a tarallo, la colonna scoliotica, l’anca sbilenca, l’apparecchio ai denti. Quel dentino eppure il sorriso contagioso.
Il corpo ingrassato di dolore, anche bello in realtà, più florido, ma il corpo di un’altra da me.
È stato se stesso invece quando ha ospitato il desiderio, ha incarnato la protezione, il coraggio. Il fallimento. È stato svuotato ed è rimasto tristemente solo, perso, per molto tempo.
Il mio corpo è cambiato quando ero incinta di Davide. Un pancino in crescita, i fianchi a fare posto, gli organi in trasferta, la schiena a sostenere, le gambe a fare le scale. Un salto per mettersi in posizione, una mano, sempre, per accarezzare.
Un corpo a due facce, dietro la donna davanti la mamma.
Un corpo in travaglio, silente, tutt’uno con la mente, concentrato al passaggio. Il dolore, fortissimo, il sentore di morte per dare la vita. Lì il mio corpo ha scoperto che non si ama solo col cuore. Gli occhi grandi si sono riempiti di occhiaie e di incanto.
Il seno piccolo ma ben fatto è diventato colmo di latte. Le braccia sottili si sono fatte forti, le gambe da maratoneta e il bacino ha avviato un dondolio per cullare. Ancora lo conservo con follia e tenerezza.
Il corpo che si fa sangue quando non dovrebbe, quando il tuo bambino si nutre e la placenta si stacca. Il crampo nel mare, il sangue per terra. La paura nel petto. Le capriole, però, le capriole nel ventre.
Il letto, o il divano, per aiutare il mio corpo. Un bimbo dentro, uno accanto. La musica, le parole, per farli sognare.
Uno squarcio, un corpo lacerato per fare passare la luce da quella ferita. Che luce, sul mio corpo.
Due braccia sono poche per due bambini. Uno nel marsupio, l’altro appeso, il passeggino non l’hanno mai amato, forse un corpo estraneo da cui guardare il mondo.
Il mio corpo al parco, il mio corpo a cucinare, il mio corpo a ballare. Il mio corpo per terra, sempre, a giocare. Il mio corpo stanco sui lettini e le mie mani nello loro, per farli addormentare.
Mamma vieni, diceva Claudio tirando un braccio. Non tirare forte – rispose Davide – se si spezzano le braccia non ci può più abbracciare.
Il corpo ha poi viaggiato alla scoperta di storie perché le mani potessero scrivere. Ha conosciuto il dolore, quello di un figlio che il suo corpo nessuno lo deve toccare. Il dolore di madre che annienta e che ha un solo obiettivo: tornare a sentirlo cantare.
Il mio corpo trafitto, accoltellato, scosso. Il mio corpo che ha imparato a parlare. Il mio corpo piegato, steso, il mio corpo che ha bisogno di cura.
Il mio corpo al lavoro. Che vorrebbe stare buttato per terra ma il mio corpo responsabile. Moltiplicato. Un pezzo per i bambini, un pezzo per il lavoro, un pezzo per la casa, la famiglia. Un pezzo per me mai, quello non l’ha ancora imparato.
Un’emergenza si è impadronita del mio tempo ma come hanno scritto i miei figli, ho ancora la gentilezza per amarli, le scarpe comode per seguirli e le mie braccia lunghissime. Posso ancora abbracciare.



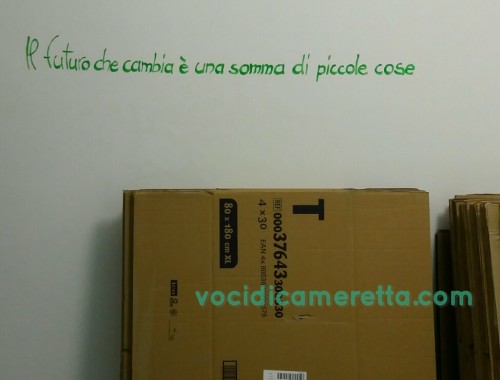

No Comments